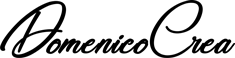Curiosita’: Lu Laganu (con una breve storia della pasta)
Nelle pitture delle tombe etrusche di Cerveteri già compaiono il mattarello e la rotella per fare la sfoglia casalinga e le strisce di pasta cotta presso i romani si chiamavano “laganum”.
Il “Laganum”, (dal greco antico λάγανον ( làganon) è un tipo di pasta che pare fosse molto apprezzato da Cicerone, certamente l’antenato delle tagliatelle che ancor oggi si chiamano “Lagane/i” in molte regioni meridionali.
Numerose citazioni dalla letteratura greca e latina fanno dedurre che questo piatto è esistito con continuità dall’epoca classica: ricordiamo Aristofane e Orazio , che usano i termini λάγανον (greco) e laganum (latino) per indicare un impasto di acqua e farina, tirato e tagliato a strisce.
La parola “lagano/a” ha anche il significato generale di impasto ammassato steso con un matterello: Il risultato sono delle fettuccine spesse, dalle dimensioni un po’ incostanti.
Nel Talmud di Gerusalemme, testo sacro degli Ebrei, si parla di itrium , un impasto di farina ed acqua
Il laganum, considerato inizialmente cibo dei poveri, acquisisce tanta dignità da entrare nel quarto libro del De re coquinaria di Marco Gavio Apicio .
Egli ne descrive minuziosamente i condimenti tralasciando le istruzioni per la loro preparazione, facendo supporre quindi che fosse ampiamente conosciuta.
“Lagane” e sfoglie di pasta conquistarono l’Impero e, come spesso accade, ogni popolo adattò la novità alle proprie esperienze.
Nella Tabula Rogeriana Al-Idrisi (1099-1166) geografo alla Corte di Ruggero II a Palermo scrisse :«Ad una giornata di cammino da Palermo, verso levante, sorge Tirmah [Termini] sopra un poggio che sta a cavaliere sul mare… A ponente di Termini è un abitato che s’addimanda ‘At Tarbî’ah [«la quadrata», Trabia], incantevole soggiorno, [ricco] d’acque perenni che [fanno muovere] parecchi mulini. La Trabia ha una pianura e dei vasti poderi nei quali si fabbrica tanta [copia di] paste da esportarne in tutte le parti, [specialmente] in Calabria e in altri paesi di Musulmani e Cristiani: che se ne spediscono moltissimi carichi di navi…» .
La parola araba per la pasta citata da al-Idrisi è quella di itriya (striscia) tradotta con «vermicelli» o spaghetti e rimasta ancora oggi nel dialetto siciliano.
E con il nome di alcune specie di pasta si tramandano anche in Puglia ed in Liguria.
A Mormanno “lu laganu” ha certamente subìto l’influenza siciliana, perciò si avvicina di più ai tagliolini o spaghetti ( tagliati molto sottili dalla sfoglia arrotolata,dalle nostre mamme in modo molto veloce e con grande abilità a non tagliarsi le dita) piuttosto che alle fettuccine, anche se a volte le strisce vengono tagliate un po’ più grandi ed ad esse si avvicinano.
Le lagane sono un tipico piatto povero e si accompagnano tradizionalmente quindi con condimenti poveri. L’accostamento tipico è con il sugo ai ceci, legumi tipici molto diffusi, ma anche con fagioli.
Furono gli Arabi del deserto a essiccare per primi le paste per meglio conservarle, poiché nelle loro peregrinazioni non avevano sufficiente acqua per confezionare ogni giorno la pasta fresca. Per permettere una rapida essiccazione, si diede alla pasta una forma di cilindretti forati.
Il più antico documento a proposito è il libro di cucina di ‘Ibn ‘al Mibrad (IX sec), dove appare un piatto comunissimo tra le tribù beduine e berbere, ancor oggi conosciuto in Siria e in Libano: si tratta della cioè maccheroni essiccati conditi in vario modo, soprattutto con lenticchie.
Altra data importante è il 1279, quando il notaio genovese Ugolino Scarpa redige l’inventario degli oggetti lasciati da un marinaio defunto, tra i quali figura anche una “bariscela plena de macaronis”.
Sappiamo che Marco Polo tornò dalla Cina nel 1295: viene così sfatata la leggenda che la pasta italiana provenga dalla Cina e che sia stato l’esploratore veneziano a introdurla in Italia (quella conosciuta in Cina, peraltro, aveva poco a che vedere con quella di grano duro tipica del nostro paese).
Ed una ricetta per le lasagne , senza pomodoro perché ancora non giunto dal “nuovo mondo”, appare nel ”liber de coquina”, un trattato della Corte di Carlo D’Angiò a Napoli alla fine del XIII secolo.
Di pochi anni dopo è il debutto della parola “maccheroni” nella forma letteraria: ne scrive il Boccaccio nel suo Decameron . con la descrizione che Maso del Saggio fa allo sciocco Calandrino del Paese di Bengodi, dove «eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli, e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva».
I maccheroni, ritenuti « cibo grossolano e da gente inferiore», vennero trattati con disprezzo dai classicisti, che coniarono l’aggettivo per indicare cosa di scarso valore letterario e scientifico.
Nacquero così le definizioni di « latino maccheronico» e di « poesia maccheronica»; a Napoli « soprattutto « maccarone senza ’o caso» e «maccarone senza pertuso», era anche sinonimo di sciocco.
Nel 1500 i maestri di paste alimentari si riunirono in sodalizi di mestiere.
Troviamo corporazioni di pastai a Roma, Napoli, Palermo, Milano e Savona e nelle città dove tale arte era meno fiorente, i pastai si immatricolavano insieme con i fornai.
A Roma regnava un’atmosfera “protezionista”: per chi vendeva pasta senza essere un fornaio erano previste forti multe e pene corporali: fino a 25 scudisciate, prigione e berlina.
Nel XVII secolo erano talmente tante le botteghe dei vermicellai di Roma, che Papa Urbano VIII, nel tentativo di regolare il commercio della pasta, in una bolla papale del 1641 impose una distanza minima di 24 metri tra un negozio e l’altro.
Fino alla seconda metà del XVIII secolo l’impasto della semola con l’acqua veniva effettuato con i piedi.
Questo metodo fu utilizzato fino a quando Ferdinando II, Re delle Due Sicilie dal 1830 al 1859, incaricò lo scienziato Cesare Spadaccini di inventare un processo meccanico.
I primi torchi idraulici comparvero intorno al 1870, mentre verso la fine del secolo la lavorazione della pasta avveniva attraverso macchine funzionanti tramite vapore o energia idraulica.
La prima macchina in grado di eseguire tutte le parti del processo produttivo fu brevettata nel 1933.
Per festeggiare l’arrivo a GRAGNANO, luogo simbolo della pasta, della Principessa Mafalda di Savoia( morta poi in un lager nazista), figlia del Re Vittorio Emanuele III, i pastai chiamarono Mafalde o Reginette un tipo di pasta simile alle fettuccine, ma con il bordo arricciato, che ricordava le onde dei merletti sulle vesti della Principessa.
Anche Mormanno è stato indissolubilmente legato alla pasta ed al Pastificio D’Alessandro, che per circa un ventennio (anni ’50 e ’60) ha venduto pasta dalla Sicilia alla Lombardia ed ha quindi garantito un accettabile tenore di vita per oltre 200 famiglie in quella comunità, evitando lo spopolamento diffuso nei paesi vicini.
L’eccellente creativo imprenditore Salvatore D’Alessandro, fondatore e direttore, fu in grado di diffondre l’ottimo prodotto (Pasta D’Alessandro –Mormanno – Calabria) e quindi anche il nome di Mormanno, stampato sui teloni degli autotreni che andavano in giro per tutta Italia e riempivano d’orgoglio quasi tutti i mormannesi!
Ho scritto “quasi” volutamente, perché un atteggiamento tipico di una minoranza (per fortuna) dei mormannesi è il sentimento dell’invidia nei confronti di chi, in ogni campo, emerge!
Spero che qualcuno, per evitarne il sicuro oblìo, vorrà scrivere la storia del Pastificio D’Alessandro a Mormanno, che purtroppo io non sono riuscito ad intraprendere.
Oggi, grazie alla qualità che le aziende produttrici continuano a migliorare nel tempo, la Pasta è certamente il più conosciuto simbolo dell’Italia nel mondo.